Cos’hanno in comune grandi capolavori della storia dell’arte italiana quali la michelangiolesca Cappella Sistina, le Stanze Vaticane di Raffaello o la giottesca Cappella degli Scrovegni? Vi siete mai chiesti come sia possibile dipingere su porzioni di spazio così grandi o godere ancora oggi di colori e di forme così splendidamente preservate, dopo più di cinquecento anni? Il denominatore comune, com’è noto, è la tecnica con cui sono state realizzate, cioè l’affresco, mentre il merito della loro incredibile conservazione è da attribuirsi a un fortunato miscuglio di chimica, di fortuna e di sapienza antica.
Innanzitutto, con “affresco” intendiamo la principale tecnica di pittura decorativa realizzata su parete (ne esistono anche altre, dai nomi più esotici, come ad esempio pittura “ad imbratto”, “a piccoli tocchi” o “a encausto”), la cui caratteristica principale è data dal trattamento del supporto (il muro) attraverso la sovrapposizione di vari strati di calce. Dipingere su parete non è, infatti, così semplice come potremmo immaginare, soprattutto se miriamo a un risultato che duri nel tempo! Erano, pertanto, richieste una certa perizia e grande rapidità – entrambe parti integranti del pedigree di artisti davvero degni di questo nome.
Preparare il muro per accogliere l’affresco era un po’ come cucinare una torta a più strati: il primo di questi, ovviamente, era la parete stessa, che costituiva la base da cui partire, realizzata in pietra o in mattoni, ruvida a sufficienza da non far scivolare via lo strato successivo, detto “arriccio”. L’arriccio era un miscuglio di acqua, calce spenta e sabbia di fiume, che andava applicato in maniera uniforme sulla parete – era un’operazione piuttosto delicata, perché proprio sull’arriccio si realizzava la prima bozza del disegno finito! Una specie di prova generale “per vedere l’effetto che faceva”… Nel corso del tempo si sono avvicendate diverse tecniche utili a restituire un’idea complessiva e a grandezza reale del risultato finale dell’affresco: la “sinopia” era semplicemente un disegno poco particolareggiato realizzato con una matita rossa direttamente sull’arriccio, mentre lo “spolvero” e il “cartone” erano l’esito di un passaggio del disegno dalla carta al muro (il primo attraverso la traccia lasciata da piccoli fori praticati in corrispondenza delle linee della composizione riempiti con polvere di carbone, il secondo da una lieve pressione esercitata dall’artista lungo gli stessi contorni, come un vero e proprio calco). Sopra agli strati di arriccio, l’artista applicava poi il “tonachino”, cioè lo strato di intonaco che avrebbe accolto il colore, realizzato mischiando sabbia fine, acqua, polvere di marmo e calce. Centrale era, infatti, la capacità di intrappolare il colore all’interno del muro, un po’ come fa l’inchiostro di un tatuaggio sulla pelle, dipingendo sull’intonaco ancora umido; la chimica, infine, attraverso la cosiddetta “carbonatazione” della calce durante il processo di asciugatura, faceva il resto del lavoro, sigillando e preservando una volta per tutte il dipinto all’interno della parete.
Per evitare antiestetiche giunture o campiture non uniformi di colore (realizzato polverizzando pigmenti minerali mischiati con acqua), gli artisti erano, inoltre, soliti lavorare “a pontate”, cioè seguendo l’andamento delle impalcature su cui dipingevano, oppure “a giornate”, tenendosi impegnati per mesi (o addirittura per anni!), date le enormi dimensioni coperte da queste decorazioni parietali. Fortunatamente (per noi), però, tutto questo impegno non è andato perduto, perché grazie alla geniale intuizione di imprigionare il colore all’interno dell’intonaco, possiamo ancora oggi godere di meravigliosi capolavori, immergendoci anche solo per un istante nello splendore di quei tempi lontani.
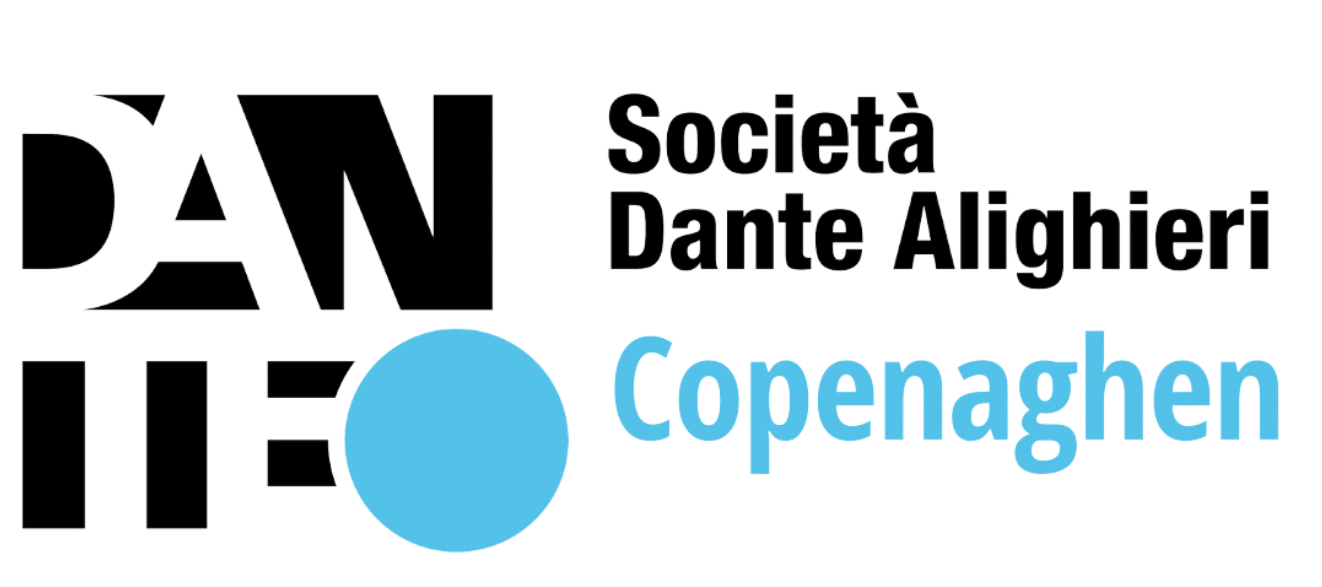




Lascia un commento